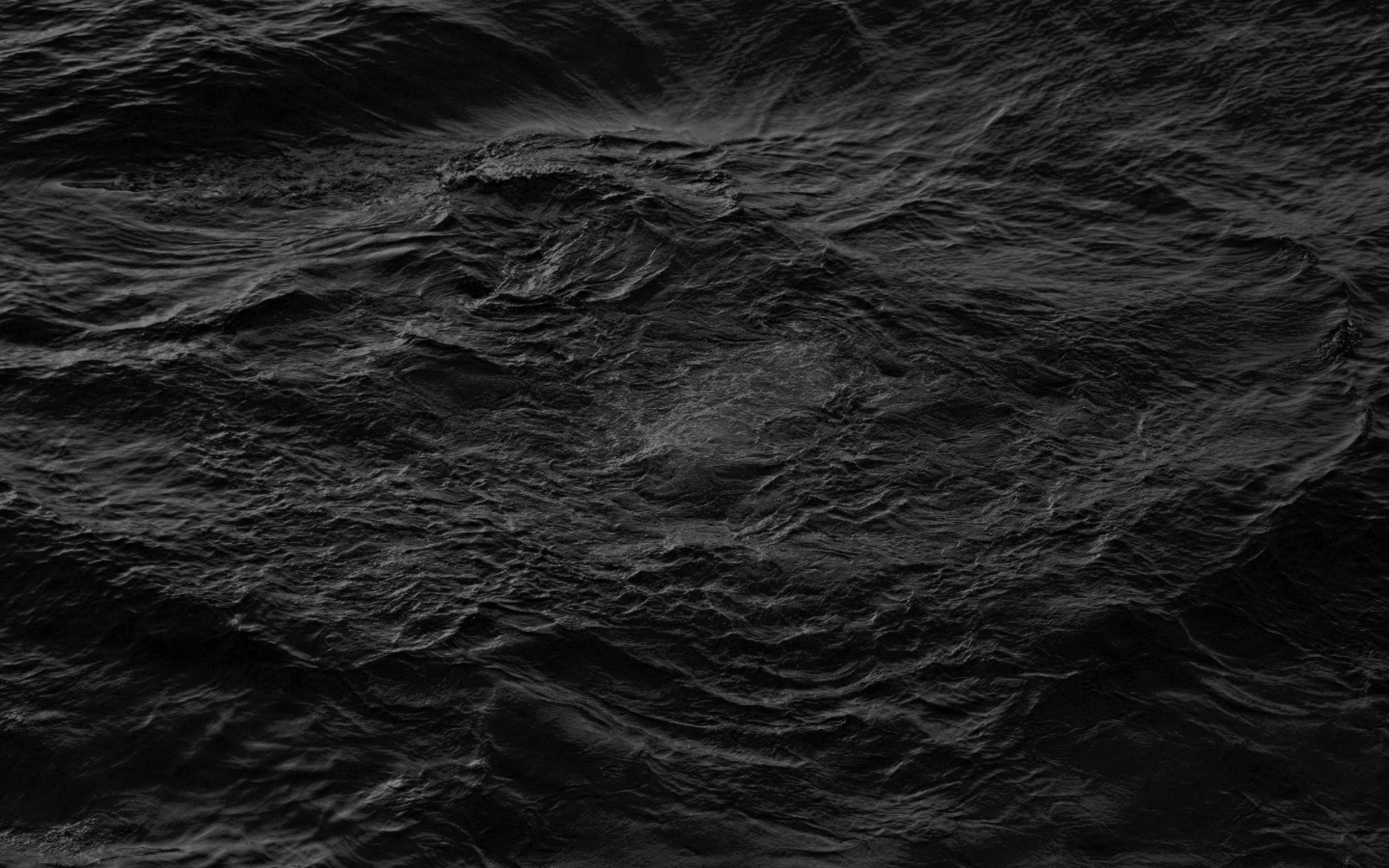Traduciamo e condividiamo questo testo scritto da Claudio Albertani nel 2003. Un’analisi approfondita e scorrevole (non fatevi intimorire dalla lunghezza, ne vale la pena, credeteci!) delle teorie di Toni Negri e più precisamente del libro “Impero”, scritto a due mani con Harendt.
Una lettura decisamente interessante, con cui viene smontata pezzetto per pezzetto, la pastura foraggia moltitudini.
Buona lettura!
L’IMPERO E LE SUE TRAPPOLE
Toni Negri e la sconcertante traiettoria dell’operAismo italiano
“Finora si è pensato che la mitologia cristiana sotto l’Impero romano fosse possibile solo perché la stampa non era ancora stata inventata. È vero il contrario.
La stampa quotidiana e il telegrafo, che diffondono le loro invenzioni in un batter d’occhio su tutta la superficie del globo, producono più miti in un giorno di quanti se ne potessero produrre in un secolo”.
Marx a Kugelmann, 27 luglio 1871.
BAUDELAIRE ha definito gli autori di trattati che spiegano in un batter d’occhio l’arte di diventare ricchi, colti e felici come “imprenditori della felicità pubblica”. Mi sembra che questa definizione si possa applicare perfettamente agli autori di Impero, che ci assicurano di avere risposte soddisfacenti alle principali domande del nostro tempo (1). Presentato come la bibbia del movimento antiglobalizzazione, il libro è stato oggetto di una grande campagna pubblicitaria, prima negli Stati Uniti (nel 2000), poi in Francia e infine in Italia e nel resto del mondo. Vero e proprio successo internazionale (mezzo milione di copie vendute fino ad oggi), tradotto in molte lingue – tra cui il cinese e l’arabo – Empire è stato accolto dalla stampa americana ed europea come un contributo di prim’ordine alla comprensione del nuovo ordine mondiale. Il quotidiano neoconservatore The New York Times non ha esitato a definirlo “l’opera più importante dell’ultimo decennio”, un’affermazione non da poco se si considera che i suoi autori si considerano radicali e si sono proposti di aggiornare il Manifesto comunista. In America Latina, invece, le reazioni sono state più tiepide e talvolta addirittura ostili, anche se, come vedremo più avanti, per le ragioni sbagliate.
UN NUOVO RIVESTIMENTO PER UNA VECCHIA IDEOLOGIA
Chiariamo subito che Impero non è affatto un manifesto, ma ancor meno un manuale per attivisti.
È un libro lungo (oltre 500 pagine), pieno di concetti oscuri come biopotere, comando globale, sovranità imperiale, autovalorizzazione, deterritorializzazione, produzione immateriale, ibridazione, moltitudine e molti altri, tutti di difficile accesso per i lettori non esperti. Una piena comprensione del libro richiede senza dubbio una certa familiarità con diverse scuole di pensiero: il post-strutturalismo francese, le teorie sociologiche nordamericane e, come vedremo, l’operaismo italiano. A tutto questo va aggiunta, con la migliore volontà del mondo, una certa conoscenza della filosofia politica, da Aristotele a John Rawls, passando per Polibio, Machiavelli e Carl Schmitt.
Devo confessare che, nel mio caso, la lettura dell’intero libro mi è costata diversi mesi di sforzi, comprese le lunghe interruzioni necessarie. Secondo i suoi stessi autori, Empire si presta a molteplici letture: il lettore può procedere dall’inizio alla fine, dalla fine all’inizio, o per temi parziali, dividendo il libro secondo i propri interessi. Mi permetto di aggiungere un altro suggerimento: la lettura per slogan o parole chiave, il cui uso elegante è oggi segno di appartenenza alla nuova sinistra o, più prosaicamente, di un aggiornamento intellettuale indispensabile per fare bella figura nei salotti letterari alla moda. Il libro si propone di esplorare la nuova configurazione del sistema capitalistico, determinata dalla globalizzazione neoliberista, e di mettere in discussione le categorie fondamentali della politica lasciate in eredità dalla modernità. Gli autori si collocano nella tradizione marxista, pur ammettendo, senza dirlo esplicitamente, che il marxismo-leninismo ortodosso ha cessato di essere rilevante. Sebbene questa rinuncia a un’ideologia che ha servito così bene gli interessi del totalitarismo sia da accogliere con favore, è sorprendente che in questo libro manchi non solo una seria analisi economica, ma soprattutto la prospettiva critica dell’economia politica che rimane, a mio avviso, l’unica eredità vivente di questa stessa tradizione marxista. Inoltre, va notato che, mentre Empire dedica decine di pagine allo studio della Costituzione statunitense, non contiene alcuna seria riflessione sulla rivoluzione russa e sul leninismo. Eppure oggi è chiaro che il modello sovietico ha aperto e chiuso lo spazio per le rivoluzioni del XX secolo. Inoltre, il suo fallimento non è estraneo all’emergere del nuovo ordine mondiale, che è appunto il tema di questo libro.
Non c’è nemmeno una discussione sulla tragedia delle rivoluzioni che si divorano da sole, né un tentativo di valutare il contributo delle correnti critiche del socialismo, sia marxiste che libertarie, che finora sono state tenute nascoste. Nelle poche pagine dedicate alla caduta del blocco sovietico, gli autori si limitano a constatare che lì la disciplina si stava “estinguendo” e ad affermare, senza aggiungere altro, che non eravamo in presenza di società totalitarie ma di una dittatura burocratica (2).
Procediamo con ordine. Impero è stato scritto tra il 1994 e il 1997, cioè dopo l’inizio della rivolta zapatista e prima della battaglia di Seattle. Una volta terminato il libro, Negri, leader politico della sinistra extraparlamentare italiana degli anni Settanta, professore universitario e autore di voluminosi trattati su Marx e Spinoza, si è consegnato alla giustizia italiana dopo quattordici anni di esilio in Francia, per rispondere di accuse legate alla lotta armata. Da qualche mese vive agli arresti domiciliari nel suo appartamento romano, dove sta lavorando al secondo volume dell’Impero. Hardt è professore di letteratura alla Duke University in North Carolina. Non conosco la sua formazione, quindi non mi propongo di analizzare il suo contributo in questa sede.
Trattandosi di un libro enormemente ambizioso, vale la pena di chiedersi come possa contribuire a una migliore comprensione del mondo di oggi. La mia risposta è che, in verità, fa ben poco. La sua tesi principale, esposta nelle primissime righe e poi ripetuta in modo quasi ossessivo, può essere riassunta come segue: con l’emergere della globalizzazione e la crisi dello Stato-nazione, appaiono nuove forme di sovranità e un nuovo sistema sociale, l’“Impero”, i cui attributi devono essere messi in evidenza. I nostri autori spiegano che gli Stati Uniti occupano un posto importante ma non centrale in questo sistema, per la semplice ragione che l’Impero non ha un centro. In un certo senso, si tratta di un Impero senza imperialismo, un’illusione condivisa dal pensiero neoconservatore. L’Impero, ci dicono, è infatti un non-luogo senza limiti, decentrato e “deterritorializzato”, che si appropria della totalità della vita sociale. Nessuna frontiera può limitare il suo potere, poiché si tratta di “un ordine che sospende di fatto il corso della storia e fissa così lo stato attuale delle cose per l’eternità” (3). Da queste affermazioni risulta chiaro che l’Impero non coincide con il sistema imperialista degli Stati sovrani in competizione tra loro. A differenza di quest’ultimo, non ha né centro né periferia, e non è più “dentro” che “fuori”, il che significa che non si può più parlare delle vecchie divisioni tra Primo e Terzo Mondo, e nemmeno di guerre imperialiste. Pur ammettendo l’esistenza di contraddizioni interimperialiste, Negri e Hardt sostengono che esse non possono essere ridotte a meccanismi classici. Che dire, inoltre, delle classi sociali nell’Impero? Non c’è più un proletariato e tanto meno un contadino (4). Esiste invece un nuovo – e misterioso – soggetto rivoluzionario, la moltitudine (al singolare, come lo Spirito Santo), di cui gli autori celebrano l’esistenza fin dall’introduzione, senza preoccuparsi di precisare i contorni del concetto.
Una volta letti questi preamboli, il lettore critico ha diverse scelte. Può ovviamente rinunciare ad affrontare un testo così astruso, ma può anche armarsi di pazienza e vagliare il contenuto delle 470 pagine (senza contare le circa 40 pagine di note) che seguono l’introduzione. È quanto ha fatto Atilio Boron che, sconvolto dalle stravaganze di Negri e Hardt, ha dedicato loro un intero libro (5). Tuttavia, se questa scelta ha il merito di fornire al lettore un inventario completo, anche se non esaustivo, delle assurdità del libro, Boron sbaglia quando descrive gli autori come post-modernisti, quando, in verità, pur prendendo in prestito concetti da Foucault (bio-potere, biopolitica) o Deleuze (deterritorializzazione, nomadismo), la loro argomentazione dipende direttamente da quello che è stato definito l’operaismo italiano, un movimento a cui Negri ha aderito negli anni Sessanta e che non ha mai rinnegato
Il pensiero degli autori del libro non nasce né dalla volontà di mettere in discussione le “grandi narrazioni” né da una sensibilità postmoderna, “attenta alla singolarità degli eventi” (6), ma soprattutto da una volontà hegeliana vorace e totalizzante: ugualmente contrari alla modernità e alla postmodernità, gli autori si collocano infatti in una sorta di etere “post-marxista” (7).
Per questo motivo, piuttosto che riprendere punto per punto le tesi – a volte francamente deliranti – del libro, la critica può scegliere un’altra strada e optare per l’esplorazione delle origini del campo in cui si inscrivono. Il tentativo è tanto più utile se si considera che, dopo gli Stati Uniti e l’Europa, l’arsenale ideologico di Negri e Hardt sta per invadere l’America Latina. A nostro avviso, non si può capire l’Impero senza conoscere, almeno nei suoi tratti più significativi, i punti di forza e di debolezza dell’operaismo italiano. Da tempo questo movimento ha dato un innegabile contributo alla ricostruzione della pratica rivoluzionaria e del pensiero critico. La sua interpretazione del marxismo ha segnato un periodo di conflitto sociale in Italia, ma c’è molta confusione sulla sua natura profonda. La letteratura in lingua spagnola, ad esempio, parla di “marxismo autonomista” e quella in lingua inglese di “autonomist Marxism” (8), termini f evocano l’idea di movimenti sociali che chiedono “autonomia” dai partiti e dalle organizzazioni politiche, cosa che, solo nel caso di Toni Negri e Mario Tronti – i due più noti rappresentanti di questa corrente fuori dall’Italia – è ben lontana dalla verità.
C’ERA UNA VOLTA UNA CLASSE OPERAIA
La corrente marxista nota in Italia come operaismo è nata negli anni Sessanta intorno alle riviste Quaderni Rossi e Classe Operaia. Tra i loro più importanti collaboratori vi erano Raniero Panzieri, Romano Alquati, Mario Tronti, Sergio Bologna, Alberto Asor Rosa, Gianfranco Faina e lo stesso Antonio Negri (9). All’epoca, l’Italia stava vivendo la fine del capitalismo agrario e del miracolo economico. Erano gli anni bui della Guerra Fredda e il Paese soffriva della doppia ingerenza di Stati Uniti e URSS. Dietro una facciata minacciosa, il Partito Comunista Italiano accettò di buon grado le regole del gioco che implicavano la sua permanente distanza dal potere centrale, in cambio di una (piccola) quota di potere locale.
La figura dominante nelle lotte sociali era l’operaio professionista, cioè l’operaio che esercitava ancora un certo controllo sul processo produttivo, che possedeva un bagaglio di conoscenze tecniche e che era consapevole di poter gestire l’azienda meglio del padrone. Si trattava di lavoratori con una forte memoria e coscienza antifascista, che dichiaravano con orgoglio di “appartenere alla nazione dei lavoratori” (10).
Le cose cambiarono presto. L’esodo rurale, il decollo industriale, la crescita del settore terziario e la diffusione dei consumi di massa hanno modificato profondamente la struttura sociale del Paese. L’esistenza di settori di lavoratori non qualificati non era certo una novità, ma in quel periodo le industrie del Nord avevano un crescente bisogno di manodopera a basso costo per guidare lo sviluppo dei settori automobilistico e petrolchimico. La produzione era frammentata e, con la diffusione della catena di montaggio, arrivò una nuova generazione di giovani emigranti dal sud, che non avevano né la cultura politica né i valori della Resistenza. Si trovavano in una situazione particolarmente difficile, perché la società locale non li accettava e il sindacato diffidava di loro. Eppure, di lì a poco sarebbero diventati i protagonisti di grandi movimenti di protesta sociale.
Il primo numero di Quaderni Rossi, pubblicato nel 1961, è dedicato all’analisi di questa nuova e complessa realtà. La rivista era pubblicata a Torino, centro nevralgico della Fiat e delle nuove forme di organizzazione del lavoro. Il suo direttore, Raniero Panzieri, era un ex dirigente del Partito Socialista, di tendenza luxemburghiana, che manteneva rapporti con la sinistra internazionale non stalinista. Qualche anno prima, nelle sue polemiche Tesi sul controllo operaio, aveva difeso l’idea della democrazia operaia di base e sostenuto che “il partito, concepito all’inizio come strumento di classe, diventa fine a se stesso, strumento di elezione dei deputati […] ed elemento di conservazione” (11).
Panzieri cercò di emancipare il marxismo dal controllo dei partiti politici e di assumere un “punto di vista operaio”, rileggendo Marx dal punto di vista della lotta di classe (12). Egli concentrò la sua attenzione sulla pianificazione e interpretò il capitale come potere sociale e non solo come proprietà privata dei mezzi di produzione. Intervenendo direttamente nella produzione, lo Stato non era più solo il garante, ma l’organizzatore dello sfruttamento. Nella quarta sezione del primo volume del Capitale, egli trovò i concetti di “comando capitalista”, “lavoratore sociale” (“lavoratore collettivo”, nella traduzione spagnola che ho consultato) (13) e “antagonismo”, che da allora sono rimasti riferimenti teorici essenziali per l’operaismo. Inoltre, è stato uno dei primi a studiare opere di Marx fino ad allora pressoché sconosciute, come i Grundrisse (in particolare il passo sulle macchine) e il sesto capitolo (inedito) del Capitale, recuperando il concetto fondamentale di “critica dell’economia politica” e le categorie di assoggettamento “formale” e “reale” del lavoro al capitale (14). In un momento in cui la sinistra ufficiale era impantanata nell’ideologia dello sviluppo, Panzieri studiò l’intreccio tra tecnologia e potere, che lo portò a pensare che l’incorporazione della scienza nel processo produttivo sia un momento chiave del dispotismo capitalista e dell’organizzazione dello Stato. In questo modo, Panzieri realizza un’inversione del marxismo ortodosso – una vera e propria rivoluzione copernicana – e apre la strada a una critica delle ideologie sociologiche, in particolare della teoria delle organizzazioni, che interpreta come tecniche volte a neutralizzare le lotte dei lavoratori (15). Molto più di altri, questo autore prematuramente scomparso (morì nel 1964) cercò di costruire un pensiero politico distinto da quello comunista, emancipandosi dallo schema dell’“intellettuale organico”, dove l’intellettuale è molto meno espressione organica della classe operaia che del solo partito.
Un’altra figura importante di questa prima fase dell’operaismo fu Romano Alquati, che intraprese una ricerca empirica nelle fabbriche, utilizzando il metodo dell’“inchiesta partecipata” (in italiano, conricerca), che prevedeva un incontro alla pari tra il soggetto e l’oggetto della ricerca – in altre parole, tra intellettuali e operai – in vista di una liberazione comune. Alquati chiamava il nuovo soggetto politico “operaio di massa” (operaio non qualificato o operaio della produzione di massa): l’operaio migrante non qualificato, totalmente separato dai mezzi di produzione, che stava per soppiantare l’operaio professionista. L’operaio di massa era l’incarnazione di tre fenomeni paralleli: 1) il fordismo, cioè la produzione di massa e la rivoluzione del mercato; 2) il taylorismo, cioè l’organizzazione scientifica del lavoro e la catena di montaggio; 3) il keynesismo, cioè le politiche capitalistiche di ampio respiro dello Stato sociale. Nel loro insieme, queste misure sono state la risposta del capitale agli operai che negli anni Venti e Trenta hanno preso d’assalto i cieli.
Gli operai ritenevano che, in Italia come altrove, le grandi trasformazioni fordiste fossero già state completate e che si stesse passando alla fase del “rifiuto del lavoro”, cioè all’alienazione totale dell’operaio dai mezzi di produzione, che portava all’assenteismo e a una più radicale messa in discussione del meccanismo dello sfruttamento. Da questo punto di vista, la storia della classe operaia appariva come un formidabile romanzo epico in cui le grandi trasformazioni produttive, dalla rivoluzione industriale all’automazione, sembravano promettere la graduale realizzazione del più antico sogno dell’umanità: liberarsi dalla fatica del lavoro. Un approccio di questo tipo era un allontanamento radicale dall’etica del lavoro, cavallo di battaglia del PCI. Secondo Sergio Bologna, “i Quaderni Rossi schiacciarono l’egemonia sui giornali di Mirafiori”, un modo per dire che la rivista si stava allontanando dal pensiero del fondatore del partito, Antonio Gramsci (16). A mio avviso, il rapporto tra gli operaisti e Gramsci era più complesso di quanto sembri: pur non approvando molto lo storicismo di quest’ultimo (Tronti e Asor Rosa, ad esempio, erano stati allievi di Galvano Della Volpe, convinto antigramsciano), apprezzavano le note su “Americanismo e fordismo”, in cui Gramsci prevedeva il passaggio a nuove forme di dominio capitalistico. Come lui, seguivano con attenzione le trasformazioni del capitalismo americano: “In America”, scriveva Gramsci, “la razionalizzazione ha determinato la necessità di elaborare un nuovo tipo umano conforme al nuovo tipo di lavoro e di processo produttivo.” (17)
Ben presto gli operaisti ebbero la certezza che il fenomeno dell’emigrazione interna tendeva ad annullare i vecchi squilibri tra Nord e Sud, al centro delle preoccupazioni di Gramsci. E questo non perché il capitalismo italiano li avesse eliminati ma, al contrario, perché la “questione meridionale” si stava estendendo a tutto il Paese, in particolare alle fabbriche del Nord, dove si stava accumulando la rabbia di questo nuovo proletariato.
Uno dei successi di questi autori fu lo sviluppo del concetto di “composizione di classe”. Così come per Marx la composizione organica del capitale esprimeva una sintesi tra composizione tecnica e valore, per gli operaisti la composizione di classe sottolineava il legame tra tratti tecnici “oggettivi” e tratti politici “soggettivi”. La sintesi di questi due aspetti determina il potenziale sovversivo delle lotte, e questo permette di dividere la storia in periodi, ognuno dei quali è caratterizzato dalla presenza di una figura “dinamica”. Ogni volta, il capitale risponde a una certa composizione di classe con una ristrutturazione a cui segue una ricomposizione politica della classe, in altre parole, l’emergere di una nuova figura “dinamica” (18). Allo stesso modo, le diverse espressioni di questa ricomposizione favoriscono una “circolazione delle lotte”.
Nell’estate del 1960 si ebbe la prima manifestazione di questa nuova composizione quando, in occasione di un congresso del partito neofascista – che allora partecipava a un governo di centrodestra – che si sarebbe tenuto a Genova, una serie di violente manifestazioni scosse quella città e alcune altre.
Ci furono diversi morti, quasi tutti giovani, e la stampa la definì sprezzantemente “una ribellione di rocker criminali” (“teddy boys”, come si diceva allora). D’altra parte, in una rubrica di un autore vicino all’operaismo, si legge che “i fatti di luglio sono la dimostrazione di classe di questa nuova generazione cresciuta nel clima del dopoguerra. [Una generazione fuori dai partiti” (19). Nel 1962 scoppia la vicenda Fiat. Scaduti i contratti di lavoro nel settore automobilistico, l’azienda si trovò al centro di una grave vertenza industriale che culminò nei violenti scontri di Piazza Statuto (7, 8 e 9 luglio) a Torino. Accusati di firmare contratti spazzatura, i sindacati ufficiali sono stati ignorati da decine di migliaia di lavoratori in sciopero, che hanno scatenato una vera e propria rivolta urbana. La polizia è riuscita a riprendere piazza Statuto solo dopo tre giorni di scontri e dopo aver ricevuto rinforzi da altre città. Ancora una volta, i protagonisti sono giovani meridionali.
Il PCI prese subito posizione, denunciando i rivoltosi come “provocatori fascisti”. Era l’inizio di una nuova fase della storia italiana: con l’emergere di nuove pratiche di confronto di classe, aumentava la distanza tra la sinistra storica e i movimenti di protesta. La discussione all’interno dei Quaderni Rossi fu molto vivace e portò a una prima scissione nel 1963. Sebbene tutti i suoi membri fossero d’accordo sul potenziale rivoluzionario della nuova situazione, c’erano serie differenze sull’atteggiamento da adottare. Panzieri optò per la cautela, mentre Tronti, Alquati, Negri, Bologna, Asor Rosa e Faina volevano passare all’azione. Questi ultimi fondarono nel 1964 Classe Operaia, un “periodico politico dei lavoratori in lotta”. L’obiettivo del gruppo non era solo quello di contribuire alla ricerca teorica, ma anche di consolidare la rete di relazioni e contatti costruita negli anni precedenti (20).
I PARADOSSI DI MARIO TRONTI
Firmato dal suo direttore, Mario Tronti, l’editoriale del primo numero di Classe Operaia – “Lenin in Inghilterra” – indicava la strada da seguire: “Stiamo assistendo all’alba di una nuova epoca della lotta di classe. Gli operai l’hanno imposta ai capitalisti con la forza oggettiva delle forze organizzate in fabbrica. […] La classe operaia guida e impone un certo tipo di sviluppo del capitale. [È necessario un nuovo inizio”. (21) Pensatore controverso e paradossale, Tronti era convinto che la recente intensificazione delle lotte operaie avesse aperto la strada alla trasformazione rivoluzionaria. Ma invece di affidarsi alla spontaneità delle masse, come Panzieri, credeva nell’intervento del partito. Le sue idee trovarono la loro formulazione definitiva nel 1966, con la pubblicazione di Operai e Capitale, un libro ricco di intuizioni brillanti e immagini suggestive, che condensava gli splendori e le miserie della seconda fase dell’operaismo. Mentre altrove i neomarxisti si perdevano in interminabili discussioni sulle teorie della crisi e del crollo del capitalismo come risultato delle sue stesse contraddizioni, Tronti affermava la centralità politica della classe operaia, sottolineava il fattore soggettivo e proponeva un’analisi dinamica dei rapporti di classe. La fabbrica non era più il luogo del dominio capitalistico, ma il cuore stesso dell’antagonismo. Il suo approccio andava controcorrente rispetto alla tradizione riformista: la lotta per i salari veniva vista come una lotta immediatamente rivoluzionaria non appena riusciva a piegare il potere del capitale. La crisi non era più intesa come il prodotto di astratte contraddizioni intrinseche, ma come il risultato della capacità dei lavoratori di strappare il reddito al capitale. Il discorso di Tronti si concentrava sulle tendenze, che sarebbero state una costante del pensiero operaista in futuro: l’obiettivo era costruire un modello teorico che permettesse di anticipare il corso degli eventi. Per questo era necessario mettere “Marx a Detroit”, cioè studiare il comportamento del proletariato nel paese più avanzato, dove il conflitto si manifestava nella sua forma più pura.
Un approccio del genere può sembrare seducente, ma le proposte pratiche che ne traiamo sono francamente deludenti: “La tradizione organizzativa della classe operaia americana è la più politica del mondo, perché la forza delle sue lotte annuncia la sconfitta economica dell’avversario e la avvicina non alla conquista del potere per costruire un’altra società nel vuoto, ma all’esplosione del lavoro salariato per ridurre il capitale e i capitalisti a una posizione subordinata in quella stessa società” (22). Sconfitta dell’avversario? Negli Stati Uniti? No, dice Tronti: in ogni caso, “la pura lotta sindacale non può farci uscire dal sistema […], abbiamo bisogno di un’organizzazione di tipo leninista” (23).
Più interessante, tuttavia, è l’analisi del rapporto tra fabbrica e società: “Al livello più alto dello sviluppo capitalistico, l’intera società diventa un’articolazione della produzione. In altre parole, l’intera società vive in funzione della fabbrica, e la fabbrica estende il suo dominio all’intera società”. (24) Contro l’interpretazione secondo cui l’estensione del settore terziario avrebbe significato un indebolimento della classe operaia, Tronti sostenne che con la generalizzazione del lavoro salariato un numero sempre maggiore di persone era in via di proletarizzazione, il che non faceva che amplificare l’antagonismo anziché ridurlo. Sebbene Operai e Capitale sia diventato un riferimento imprescindibile per i militanti del ’68, è curioso notare come l’autore di quest’opera non abbia mai lasciato il PCI e sia tuttora membro del PDS post-comunista. Meglio ancora, Tronti ha recentemente spiegato che l’interpretazione di sinistra del suo libro è stata frutto di un errore. “Non sono mai stato uno spontaneista. Ho sempre pensato che la consapevolezza politica dovesse venire dall’esterno”. (25)
A prescindere dalle opinioni che Tronti professa oggi, però, è chiaro che negli anni Sessanta lui e gli operai aprirono un fronte contro la tradizione nazional-popolare della sinistra italiana, che abbracciava non solo la politica ma anche la cultura (filosofia, letteratura, cinema e scienze umane), e diedero una prima risposta alle teorie del “dominio totale” accettate da tutti, anche dalla sinistra critica. Ciò che sembra più attuale in Operai e Capitale è sicuramente la critica al logos tecno-produttivista, sia marxista che liberale, e all’idea – già presente in Panzieri – che il sapere sia legato alla lotta, che non sia neutrale ma di parte (26).
Il libro di Tronti rimane un serio tentativo di rinnovare il marxismo, anche se non ha portato a nulla (27). Il suo “soggettivismo” esprimeva una ribellione contro l’oggettivismo del marxismo volgare, compreso quello della Scuola di Francoforte, con l’eccezione di Marcuse. Tronti percepisce il “progetto” del capitale di controllare la società nel suo complesso, ma, contrariamente ad Adorno, lo interpreta come una strategia per contenere la protesta dei lavoratori (28). Questo soggettivismo fu, allo stesso tempo, fonte di molti errori, il più grave dei quali fu quello di ritenere che la logica dello sviluppo capitalistico non si basasse sull’estrazione del profitto, ma sulla combattività dei lavoratori. Tale approccio lo allontanava da Panzieri e dal primo operaismo, che concepivano il capitale e la classe operaia come due realtà antagoniste ugualmente “oggettive”. Inoltre, Panzieri non commetteva l’errore di pensare che gli aumenti salariali potessero causare la rottura del sistema (29).
Senza pretendere di essere un “vero” marxista a tutti i costi, appare chiaro che l’approccio di Tronti si basa su una lettura parziale di Marx e, ancor più, su una grossolana semplificazione della realtà. Se è vero che Marx ha scritto che la lotta di classe è il motore della storia, la sua analisi si concentra sul rapporto sociale tra due poli contraddittori: da un lato il capitale come potere sociale, il lavoro “morto”, l’oggettività pura, lo spirito del mondo, e dall’altro il lavoro “vivo”, la classe operaia che, in quanto parte integrante del rapporto, ne è al tempo stesso la negazione. L’origine della contraddizione è dovuta alla duplice natura del lavoro operaio, che è sia lavoro astratto, che produce plusvalore, sia lavoro concreto, che produce valore d’uso. Il problema – aggiungeva – è che “il valore non porta in faccia ciò che è” (30). Secondo Marx, le antinomie tra “soggettivismo” e “oggettivismo” non possono essere risolte nella teoria, ma nella pratica (31), poiché solo la creazione di un nuovo modo di produzione – la famosa negazione della negazione o espropriazione degli espropriatori – può raggiungere questo obiettivo.
Con Tronti, invece, c’è un’ipostasi del polo soggettivo: “il capitale come funzione della classe operaia” (32). Questo lo porta a trasformare la classe operaia nel fondamento ontologico della realtà. La soggettività non era più la forza concreta di individui coscienti che si organizzavano per cambiare il mondo, ma – per Tronti – una semplice categoria ermeneutica per comprendere il capitalismo. Quanto al negativo, era andato in fumo.
Vale la pena sottolineare che, quasi quarant’anni dopo, lo stesso schema è costantemente all’opera nell’Impero. Qui il soggettivismo estremo, la lettura della storia dal punto di vista del “potere” dei lavoratori, diventa puro delirio: “Dalla manifattura alla grande industria, dal capitale finanziario alla ristrutturazione transnazionale e alla globalizzazione dei mercati, sono sempre le iniziative del lavoro organizzato a determinare le configurazioni dello sviluppo capitalistico”. O ancora: “Arriviamo così al delicato passaggio attraverso il quale la soggettività della lotta di classe trasforma l’imperialismo in Impero”. Per questo è necessario comprendere “la natura globale della lotta di classe proletaria e la sua capacità di anticipare e prefigurare gli sviluppi del capitale verso la realizzazione del mercato mondiale” (33). In questo passaggio, e in molti altri simili, la dialettica operai-capitale – questa “grammatica della rivoluzione”, per usare la magnifica espressione di Alexander Herzen – svanisce nell’apologia di un presente senza contraddizioni.
Se i lavoratori sono già così forti e potenti, perché dovrebbero fare la rivoluzione?
ROTTURE
La funzione principale di Classe Operaia fu senza dubbio quella di favorire l’articolazione dei vari gruppi locali che lavoravano sulla questione operaia in diverse parti del Paese. Tuttavia, il gruppo ebbe vita breve, terminando nel 1966 (34). Perché? In una riunione tenutasi a Firenze verso la fine del 1966, Tronti, Asor Rosa e lo stesso Negri posero la questione dell’urgenza di una svolta politica. Il tema centrale era il rapporto classe-partito: la classe incarnava la strategia e il partito la tattica. C’era però un problema: mentre la prima era ben consapevole del lavoro di demolizione che l’attendeva, il secondo stava perdendo l’orientamento. In queste condizioni, piuttosto che aggiungere benzina al fuoco delle proteste operaie, era necessario entrare nei sindacati, e soprattutto nel PCI. L’idea era quella di formare una sorta di leadership operaia per farle svolgere il ruolo di “cuneo” (questa era l’espressione usata) nel Partito e modificarne così l’equilibrio interno (35).
Va sottolineato che, fino ad allora, l’operaismo era stato un laboratorio collettivo, una sorta di rete informale composta da intellettuali, sindacalisti, studenti e rivoluzionari di varie tendenze accomunati da una sensibilità antiburocratica e dalla scoperta di un nuovo mondo operaio in lotta. Ad eccezione di Tronti, nessuno aveva affrontato apertamente la questione del leninismo. Si accettava il Lenin che aveva capito la convergenza tra crisi economica, crisi politica e tendenza all’autonomia dei lavoratori, ma non si affrontava la questione del partito.
Una minoranza libertaria – integrata da Gianfranco Faina, Ricardo d’Este e altri militanti genovesi e torinesi – non accettò questa scelta a favore dell’operaismo. Per loro l’operaismo si basava sull’idea che le forze sovversive si aggregassero al di fuori della logica dei partiti e dei sindacati ufficiali. Trovarono ispirazione nel comunismo conciliare (36), negli anarchici spagnoli e in Amadeo Bordiga (37). Negli anni successivi condivisero le posizioni libertarie del gruppo Socialisme ou Barbarie e dell’Internazionale Situazionista, rompendo definitivamente con ogni pretesa di “guida” del movimento (38). Un’altra tendenza, guidata da Sergio Bologna, cercò di attenersi all’operaismo originario, tornando al duro lavoro alla Fiat e in poche altre fabbriche lombarde (39). Di conseguenza, la svolta annunciata non si realizzò e Tronti dovette ammettere di non essere riuscito a “realizzare il circolo virtuoso di lotta, organizzazione e possesso del terreno politico” (40).
Allo stesso tempo, eventi importanti complicarono il progetto di conversione del PCI all’operaismo (41). Nel 1968 la temperatura sociale in Italia cominciò a salire a livelli preoccupanti. Cominciano a diffondersi nuovi e sempre più intensi fermenti culturali. I problemi nazionali si intrecciano con la situazione internazionale della fine degli anni Sessanta (proteste contro la guerra in Vietnam, le Pantere Nere, ecc.), inaugurando un periodo di grandi cambiamenti. I primi ad agire furono gli studenti che occuparono le principali università del Paese: Trento, Milano, Torino e Roma. Iniziarono contestando l’autoritarismo universitario e finirono per criticare il capitalismo, lo Stato, la patria, la religione, la famiglia e così via. Mostrarono particolare disprezzo per i partiti di sinistra, accusati di essere diventati ingranaggi fondamentali del regime. Alla fine del 1968, e soprattutto nel 1969, quando le proteste operaie si intensificarono, il sistema entrò in crisi. Il grande sommovimento sociale, che in altri Paesi si era consumato in pochi mesi, in Italia durò quasi dieci anni, e in questo risiede senza dubbio l’unicità di questo movimento. Va da sé che questa esplosione di radicalismo legittimò le ipotesi liriche più ardite. La “strategia del rifiuto” si stava realizzando. Eppure Tronti sosteneva che non stavamo assistendo alla nascita di una nuova epoca, ma piuttosto all’ultimo – e più disperato – slancio di un ciclo di lotte che si stava concludendo.
Oggi possiamo vedere innegabili elementi di verità in questo pessimismo, ma all’epoca tutto sembrava ancora in sospeso. Improvvisamente, Tronti dava allo Stato attributi che negavano tutto ciò che aveva scritto fino a quel momento. Non c’è più “autonomia, autosufficienza o autoriproduzione della crisi al di fuori del sistema di mediazione politica delle contraddizioni sociali”. Tradotto in un linguaggio più chiaro, questo significava che la lotta economica non poteva più essere politica e che la classe operaia, fino ad allora vista come forza antagonista, era diventata la “sola razionalità dello Stato moderno” (42). Agli occhi di Tronti l’utopia stava davvero finendo, ed è questo che cercava di trasmettere parlando di “autonomia della politica”, un’ideologia che ebbe vita breve, anche se accompagnò l’evoluzione di alcuni operai – il critico letterario Alberto Asor Rosa e il giovane germanista Massimo Cacciari – verso l’accademismo e il PCI, dove furono accolti come pentiti. La convinzione dell’esistenza di una sfera politica “pura” all’interno dello Stato servì ad altri per iniziare una lunga marcia all’interno delle istituzioni.
All’interno del PCI ci fu un (breve) dibattito sull’opportunità di cavalcare la tigre del movimento, ma alla fine prevalsero le posizioni più conservatrici, al punto che il gruppo del Manifesto (Rossanda, Pintor, Magri) venne escluso. Questa fu l’ingloriosa conclusione del percorso di un settore dei “marxisti autonomisti”. Per quanto riguarda gli altri, la maggior parte di loro, compreso Antonio Negri, vedeva nella nuova situazione la possibilità di portare avanti una politica rivoluzionaria al di fuori dei partiti di sinistra, e persino contro di essi. Nel 1969 si moltiplicano i gruppi e i cavalli di battaglia dell’estrema sinistra, che si propongono di riprodurre in Italia la strategia bolscevica – nelle sue varie versioni: leninista, trotskista, stalinista e maoista – con la creazione di un partito di estrema destra finalizzato alla presa del potere. Gli operaisti fondarono Potere Operaio e Lotta Continua, gruppi che gravitavano anch’essi verso il marxismo-leninismo, pur non mostrando particolari simpatie per il modello sovietico e nemmeno, diciamolo pure, per quello cinese.
Se il progetto era irreale, i conflitti erano autentici e, man mano che i gruppi sovversivi guadagnavano terreno, lo Stato diventava sempre più aggressivo. Il risultato fu la “strategia della tensione”, una serie di attentati e omicidi compiuti dai servizi segreti italiani tra il 1969 e il 1980 con la complicità dei governi successivi. Non c’è il minimo dubbio – e ci sono decine di documenti che lo dimostrano – che in Italia il terrorismo sia stato inizialmente appannaggio dello Stato stesso e non dei movimenti di estrema sinistra (43).
Poiché la storia di questi tragici eventi esula dagli scopi di questo studio (44), mi limiterò qui a fare le seguenti tre considerazioni: 1) adottando la strategia del compromesso storico nel 1974 – che mirava, per i comunisti, a entrare nel governo attraverso un’alleanza strategica con la Democrazia Cristiana – il PCI si spostò ancora più a destra, contribuendo così a legittimare la criminalizzazione di ogni dissenso; 2) questo sviluppo, insieme alle stragi di Stato, finì per convincere un gran numero di militanti che l’unica strada percorribile fosse quella militare e che fosse necessario un partito strutturato verticalmente, gerarchico e clandestino; 3) la lotta armata fu un errore dalle conseguenze incalcolabili, che portò il movimento verso un sanguinoso confronto – destinato al fallimento – con lo Stato.
LE AVVENTURE DELL’OPERAIO SOCIALE
È in questo contesto che dobbiamo analizzare il pensiero dell’uomo che è subentrato all’operaismo: Antonio Negri. Egli ha spesso descritto il proprio percorso. Nato da una famiglia modesta, ha studiato all’Università di Padova, dove ha scritto una tesi sullo storicismo tedesco, per poi proseguire gli studi in Germania e in Francia. Ha avuto una brillante carriera accademica, pubblicando una ventina di libri e un numero impressionante di articoli in riviste di tutto il mondo. Dalla fine degli anni Cinquanta, accanto all’attività didattica, si impegnò nell’azione politica, prima in settori cattolici, poi all’interno del Partito socialista e infine nel movimento operaista (45).
Il contributo di Negri non fu determinante nella prima fase, fino a Classe Operaia, ma lo divenne con la fondazione di Potere Operaio. Il gruppo nacque nell’estate del 1969, nel contesto di una crisi del movimento studentesco, la cui causa, dal punto di vista marxista-leninista, risiedeva nel fatto che le rivolte studentesche avevano senso solo se subordinate all’“egemonia operaia”, cioè alla linea dell’organizzazione. Era quindi urgente, da questo punto di vista, costruire una leadership politica che le incanalasse in questa direzione. Negri avanzò l’idea di costruire un partito centralizzato, “compartimentato” e verticale. “La nostra analisi si basa sul lavoro dei classici, di Marx, Lenin e Mao. Nella nostra organizzazione non c’è spazio per gli umori o i desideri”, scriveva in un testo che lasciava poco spazio alle interpretazioni ‘autonomiste’ (46).
A differenza di Lotta Continua (LC), gruppo più incline all’attivismo, Potere Operaio (PO) attribuiva una certa importanza allo sviluppo teorico che ruotava intorno a un’interpretazione estremista delle origini dell’operaismo. La soggettività non risiedeva più nella classe, ma nell’avanguardia comunista, cioè nel gruppo PO. Era quindi necessario centralizzare e radicalizzare gli antagonismi spontanei per trasformarli in azioni insurrezionali contro lo Stato. Ancora una volta, il tentativo fallì. Il ciclo di lotte iniziato nei primi anni Settanta entrò nella sua fase calante e una delle sue ultime manifestazioni fu l’occupazione dello stabilimento Fiat di Mirafiori (a Torino), che nel marzo 1973 pose fine all’epoca dei grandi scontri tra operai e capitale. Uno dei lasciti di questa lotta fu lo Statuto dei Lavoratori, un insieme di disposizioni favorevoli al mondo del lavoro, oggi ridotto a un guscio vuoto.
Alla fine del decennio, i conflitti sociali persistono, ma il loro centro di gravità non è più nelle fabbriche. Mentre le principali formazioni extraparlamentari entravano in crisi (il PO si sciolse nel 1973 e la LC nel 1976), una costellazione di piccoli gruppi stava emergendo attorno allo slogan “Prendiamo la città”. Alcuni di questi gruppi presero il nome di “Indiani metropolitani” o “Gioventù proletaria”. Occuparono edifici, crearono centri sociali, fondarono riviste, diedero vita a progetti di comunicazione alternativa e crearono associazioni femministe e ambientaliste.
Con una base militante sia nelle fabbriche che nei quartieri, questi gruppi iniziarono ad abbandonare le vecchie concezioni del partito separato e del dirigismo leninista, alla ricerca di alternative nell’organizzazione di spazi di convivenza e scambio sociale autonomi dalla legalità dominante. Per sottolineare la loro indipendenza politica, utilizzarono sigle che includevano la parola “autonomo” – ad esempio, “Proletari autonomi” o “Assemblea autonoma” – in modo da iniziare a essere identificati come “zona di autonomia operaia” (47).
Negri interpretò la nuova fase con un trionfalismo militante che era l’esatto contrario del pessimismo di Tronti (e della sua “autonomia del politico”). Per lui non si poteva tornare indietro: il rifiuto del lavoro taylorista aveva abbattuto i muri che separavano la fabbrica dal territorio. L’intero processo sociale era ora mobilitato per la produzione capitalistica, aumentando così l’importanza del lavoro produttivo. In questa nuova situazione, l’operaio di massa lascia la fabbrica e si trasferisce nel territorio, la fabbrica diffusa, per diventare l’operaio sociale, il nuovo soggetto di cui il nostro autore inizia a proclamare la centralità. Tecnici, studenti, insegnanti, operai, immigrati e squatter finiscono tutti nello stesso sacco, senza che Negri presti la minima attenzione alle loro differenze, alle loro specificità e alle loro contraddizioni.
Con l’intento di rovesciare le categorie di Marx, introduce nella sua analisi la categoria dell’autovalorizzazione (la stessa che riapparirà, senza ulteriori spiegazioni, un quarto di secolo dopo in Impero) (48). Che cosa significa? Mentre la valorizzazione capitalistica si basa sul valore di scambio, l’autovalorizzazione – il perno dell’edificio teorico di Negri – si basa sul valore d’uso e sui nuovi bisogni dei proletari. Generalizzando le pratiche di autovalorizzazione su tutto il territorio – la fabbrica diffusa – l’operaio sociale doveva d’ora in poi lottare per il “salario garantito”.
Da quel momento in poi, per Negri, il cuore del conflitto (e quindi dell’analisi) si sposta sullo Stato. Negri riteneva che lo Stato keynesiano – che chiamava “piano-stato” – avesse inscritto le conquiste della Rivoluzione d’Ottobre nel cuore dello sviluppo capitalistico, trasformando il “potere dei lavoratori” in una “variabile indipendente”. Per lui, la lotta principale si svolgeva ora sul terreno dell’autovalorizzazione e, poiché non vi era più alcuna riproduzione del capitale al di fuori dello Stato, la “società civile” cessava di esistere, lasciando solo due grandi avversari: i proletari e lo Stato (49).
Nonostante l’apparente coerenza, questo ragionamento si basa su un’interpretazione errata del concetto marxista di valore. Per Negri, il valore d’uso esprimeva la radicalità dei lavoratori, la loro potenzialità soggettiva, come antagonista del valore di scambio. In un certo senso, era il lato “buono” della relazione. Tuttavia, dal punto di vista della critica dell’economia politica, questo approccio non ha senso, perché, come spiega Marx nel primo capitolo del primo volume del Capitale, il valore d’uso non è affatto una categoria morale, ma la base materiale della ricchezza capitalistica, la condizione della sua accumulazione.
Se, in qualsiasi momento del processo di circolazione, i valori d’uso non vengono trasformati in valori di scambio, cessano di essere valori e, in questo senso, limitano e condizionano il processo di valorizzazione.
Una delle fonti di Negri era Agnès Heller, una delle più note esponenti della scuola di Budapest, che aveva posto il concetto di bisogni radicali al centro delle sue riflessioni su Marx. Era però attenta a non scadere in un’apologia dei bisogni immediati. Il bisogno economico”, scriveva, “è un’espressione dell’alienazione capitalistica in una società in cui il fine della produzione non è la soddisfazione dei bisogni, ma la valorizzazione del capitale, in cui il sistema dei bisogni è basato sulla divisione del lavoro e sulla domanda del mercato”. (50) Negri, invece, non ha evitato l’apologia e si è così allontanato dal marxismo critico, dimenticando che non si può combattere un mondo alienato in modo altrettanto alienante. Inoltre, l’autonomia non può esprimersi nella condizione immediata della classe. Sotto il dominio del capitale, l’autonomia è un progetto, una tendenza o, più precisamente, una tensione. Può essere costituita come realtà pratica solo in momenti di rottura, in spazi decolonizzati. Quando questa realtà pratica si socializza, arrivano i grandi momenti di crisi amministrativa, come in Francia nel 1968 o in Italia nel 1977. Contrariamente alla visione di Negri, il comunismo non è “l’elemento dinamico costitutivo del capitalismo” (51), ma un’altra società senza antagonismi di classe, senza potere statale e senza feticismo mercantile.
E il partito? “Nella mia coscienza e pratica rivoluzionaria non posso ignorare questo problema”, scriveva colui che si considerava il Lenin italiano, aggiungendo che era “urgente lanciare il dibattito sulla dittatura comunista” (52). Il partito, infatti, rimaneva un compito incompiuto, anche se esisteva già in embrione, insieme all’Autonomia Organizzata (con la maiuscola, per distinguerla nettamente dalle altre autonomie), cioè tutte le organizzazioni semiclandestine e i loro servizi di sicurezza militarizzati che, spinti dalla repressione statale, praticavano la lotta di classe con l’intento di “filtrare” e “ricomporre” l’antagonismo delle masse in vista della lotta finale (53).
Il risultato fu catastrofico. Il sogno di prendere il potere si scontrò presto con gli scogli della realtà. A partire dal 1977, l’ultima grande stagione creativa del “laboratorio Italia”, il PC fece fronte comune con la Democrazia Cristiana al governo. La repressione entra in una nuova fase, schiacciando tutto ciò che va oltre la sinistra parlamentare e cancellando la differenza tra terrorismo e protesta sociale.
Ciascuna per conto proprio, e spesso in competizione con l’altra, l’Autonomia organizzata – o meglio, alcune delle sue organizzazioni (54) – e le Brigate Rosse neostaliniste continuarono il loro assurdo assalto al “cuore dello Stato” (come se lo Stato avesse un cuore!), trascinando nella loro rovina il ricco e complesso tessuto dell’autonomia con la “a” minuscola (55).
Già nel 1978, in occasione dell’esecuzione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse (uno degli errori più dannosi mai commessi da un gruppo rivoluzionario, con le conseguenze più negative), e pur esprimendo il proprio dissenso, Negri poteva scrivere che il lato positivo dell’azione era quello di aver imposto al movimento la “questione del partito” (56). Il 7 aprile 1979, l’allucinazione si concluse nel modo più tragico, quando Negri e decine di militanti dell’Autonomia furono imprigionati con la (falsa) accusa di essere ideologi delle Brigate Rosse. Dovranno trascorrere dai due ai sette anni in carcere, designati dalla meschinità delle autorità come vittime degne di essere sacrificate sull’altare della pace sociale (57). Nel 1980, l’ultimo tentativo di occupazione della fabbrica di Mirafiori segnò la fine simbolica di un lungo ciclo di conflitti sociali in cui, caso unico nella storia europea, le lotte operaie e studentesche e i movimenti per la reinvenzione della vita si erano sviluppati insieme in un formidabile tentativo di liberazione collettiva (58).
LE GESTA DELLA MOLTITUDINE
Nei due decenni successivi, Negri non ha abbandonato l’abitudine di leggere i movimenti sociali come verifica delle sue tesi, scrivendo numerosi (e criptici) lavori, senza mai abbozzare la minima autocritica.
Da Foucault, Deleuze e Guattari, il nostro autore ha ereditato una forte avversione per la dialettica (59). Già nel suo studio dei Grundrisse, frutto di un seminario a Parigi, scriveva che “l’orizzonte metodico marxiano non si incentra mai sul concetto di totalità”. Al contrario, esso “è caratterizzato dalla discontinuità materialista dei processi reali”, in modo tale che il materialismo subordina la dialettica a se stesso (60).
Negri vede la società capitalista come un campo di forze in costante lotta. A differenza dei poststrutturalisti francesi, però, egli ritiene che la forza motrice dei processi sociali sia la separazione o, in altre parole, l’antagonismo sociale. Spetta alla riflessione individuare l’antagonismo decisivo, scrutarne le tendenze e condurlo all’esplosione. Subito dopo, l’analisi si sposta su un nuovo campo, lo ridefinisce e così via (61). Il capitale non è più concepito come una contraddizione in atto (Marx), ma come l’affermazione progressiva di un soggetto conosciuto in anticipo.
Nel libro Spinoza, l’anomalie sauvage (Spinoza, l’anomalia selvaggi, scritto in carcere, Negri definisce progressivamente il suo progetto: lavorare sulla costituzione materiale della soggettività radicale in Occidente, allargando il divario tra le filosofie del potere e quelle della sovversione. Intorno a Spinoza vede condensarsi una tradizione “anomala” che, affermando la produttività del soggetto, si estende da Machiavelli a Marx, contro l’asse incarnato dalla triade Hobbes-Rousseau-Hegel (62). Negri trova in Spinoza una critica anticipata della dialettica hegeliana, nonché la nascita del materialismo rivoluzionario. In questo modo, Negri oppone all’invenzione staliniana del diamat un nuovo orizzonte ontologico basato sulla categoria spinozista di potenza. Questo approccio ignora le critiche al marxismo sovietico formulate cinquant’anni prima dai comunisti di sinistra, ovvero che il materialismo marxiano non è né una filosofia né un’economia, ma la teoria rivoluzionaria del proletariato in lotta. Per la sinistra radicale, il movimento dialettico non ha mai espresso una legge universale della storia, e ancor meno una scienza, ma “la logica specifica di un oggetto specifico”, il capitalismo, un sistema sociale opaco basato sul “feticismo” (63).
È nel suo libro su Spinoza che Negri introduce per la prima volta il concetto di moltitudine, ovvero il nuovo soggetto globale che avrebbe gradualmente soppiantato l’operaio sociale e lo avrebbe trasformato, quasi vent’anni dopo, nell’indiscutibile eroe dell’Impero (64). Da dove viene questa moltitudine tanto annunciata (65)? Agli albori della modernità, Hobbes e i filosofi della sovranità diedero questo nome al gruppo di persone prima che diventasse un popolo (66). La moltitudine, tuttavia, era per loro qualcosa di puramente negativo, riferendosi a un insieme umano indifferenziato e selvaggio, non ancora organizzato in uno Stato. Negri rovescia il concetto, considerandolo il fondamento indispensabile della democrazia radicale (67). La moltitudine contemporanea sarebbe la forma di esistenza sociale e politica del “più numeroso”, dell’“insieme aperto” che si pone come alternativa alla costellazione popolo-volontà generale-Stato.
C’è di più. Interpretando in modo unilaterale le affermazioni di Marx, Negri sembra sostenere che il capitalismo si è già estinto come modo di produzione e sopravvive solo come puro dominio o “dispositivo di controllo” (73). Come se non bastasse, egli guarda a tutte le utopie tecnologiche, dalla “fine del lavoro” ai miti della società post-industriale e alle antropologie del cyberspazio. “Nell’espressione della propria energia creativa, il lavoro immateriale sembra quindi fornire il potenziale per una sorta di comunismo spontaneo ed elementare”. (74) Nell’interpretazione di Negri, il comunismo non nasce più dall’antagonismo o dal rifiuto collettivo della cooperazione capitalistica ma, al contrario, dalla sua maggiore estensione grazie alla scienza e alla tecnologia. Arriva a sostenere le più antiche cause neoliberali: il nuovo federalismo, l’Unione Europea e persino gli “imprenditorialità comune” del Veneto, “tutti coloro che hanno messo la loro energia, la loro intellettualità, il loro lavoro e la loro inventiva al servizio della comunità” (75). Così il cerchio si chiude: l’operaismo di Negri porta a un’apologia delle forze produttive molto simile a quella che Panzieri aveva giustamente rifiutato circa quarant’anni prima. E, proprio come con Tronti, scompare ogni nozione di autonomia concreta basata sull’azione indipendente dei soggetti sociali in lotta, così che i due avversari di trent’anni fa si ritrovano di nuovo insieme (76).
Infine, è a dir poco divertente vedere Negri e Hardt evocare, alla fine del loro libro, San Francesco come figura paradigmatica del nuovo militante (77). Nei movimenti sociali di oggi, preferiscono la parola “attivista”, che fa meno paura e si riferisce maggiormente all’azione diretta. Le azioni festose dei giovani (e meno giovani) che da Seattle in poi tengono svegli i potenti del mondo hanno poco a che fare con la “militanza” (78). Ciò che li sostiene, al contrario, è il desiderio giocoso di “rovesciare la prospettiva”, di abbandonare la politica tradizionale e di creare nuove forme di comunità (79).
Per tornare al tema del concetto di moltitudine e misurarne l’efficacia, è importante sottolineare che tutti i cambiamenti vissuti dal capitalismo negli ultimi decenni hanno completamente dissolto qualsiasi centro di gravità nelle lotte antisistema. Il marxismo stesso è oggi solo una delle tante teorie che i nuovi movimenti possono utilizzare per armarsi concettualmente. Ce ne sono altre: l’anarchismo, le cosmovisioni tradizionali, la teologia della liberazione e così via. La storia, inoltre, non si fa più solo in Occidente. Oggi i movimenti sociali sono plurali per definizione.
Che cosa hanno in comune gli indigeni del Chiapas e gli operai della Fiat, gli agricoltori ecologisti della Francia e i rivoltosi dell’Argentina, i contadini del Karnakata e i cyberpunk della metropoli postmoderna? Probabilmente molto, come spiega il Subcomandate dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN): “I governi pensano che noi indios non conosciamo il mondo. Ebbene, dovrebbero sapere che lo conosciamo e che siamo consapevoli dei piani di morte che vengono elaborati contro l’umanità e anche delle lotte dei popoli per la loro liberazione. Conosciamo il mondo, anche il Giappone. Perché conosciamo tutti gli uomini e le donne che sono venuti nei nostri villaggi e ci hanno raccontato le loro lotte, i loro mondi e tutto ciò che fanno. Attraverso le loro parole, abbiamo viaggiato, visto e sperimentato più cose della terra di quanto potrebbe fare qualsiasi intellettuale”. (80) È importante rifare il prima possibile questo mondo che non ci appartiene. Ogni soggetto, ogni movimento, ogni comunità in lotta cerca l’incontro con l’altro, ma allo stesso tempo chiede di mantenere la propria prospettiva e identità. E questo mi sembra un grande passo avanti. Non è un caso, ad esempio, che i movimenti indigeni in Mesoamerica parlino sempre meno di interculturalità e sempre più di multiculturalità. Mentre il primo concetto postula una sintesi obbligata, il secondo preserva tensioni e particolarità.
Non c’è dubbio che abbiamo bisogno di nuovi concetti per evidenziare queste differenze, e Negri ha ragione a criticare il concetto di “popolo”. Ma perché, in questo caso, schiacciarle annullandole all’interno di un’astrazione filosofica vecchia di tre secoli? Come il suo antecedente, l’operaio sociale, la moltitudine è un concetto forzato. Alla fine del suo percorso, Negri ritorna al peccato originale dell’operaismo italiano: la ricerca incessante della “centralità”, qualunque essa sia, il feticismo del lavoro produttivo, l’incapacità di andare oltre l’orizzonte della fabbrica (81). Il risultato è un soggetto senza storia, una forma senza contenuto, l’ultimo adattamento della vecchia torsione con cui la classe operaia non smette di tormentare il capitalismo.
EPILOGO. LA FINE DELLO STATO NAZIONE?
Nonostante la sua dichiarata avversione per il pensiero dialettico, la costruzione teorica di Negri non ha mai smesso di essere hegeliana (82). Sia nell’Impero che nei suoi libri precedenti, l’idea di Negri di una teologia necessaria, di un movimento circolare e di un lieto fine, già presente negli inizi, è sempre sottesa. Ci viene detto, ad esempio, che le rivoluzioni del XX secolo non sono mai state sconfitte, ma che “tutte hanno spinto in avanti e trasformato i termini del conflitto di classe, ponendo le condizioni di una nuova soggettività politica” (83). In altre parole, hanno preparato la strada all’evento della realtà ultima del nostro tempo, l’Impero, e del suo necessario nemico, la moltitudine. Così come lo spirito del mondo si manifesta gradualmente nella Storia saltando da una parte all’altra del mondo, l’epifania imperiale si incarna in tappe e figure notevoli che, in ogni momento, le conferiscono caratteristiche distintive.
L’epopea inizia nel negozio di Spinoza e uno dei suoi episodi centrali è, a quanto pare, la Costituzione americana, perché si basa “sull’esodo, su valori affermativi piuttosto che dialettici, sul pluralismo e sulla libertà” (84). Qui si assiste al ritorno del vecchio attaccamento lirico agli Stati Uniti, ora condito da alcune (infelici) dichiarazioni di Hannah Arendt sulla Rivoluzione americana (85).
Noam Chomsky, senza dubbio uno dei migliori analisti degli Stati Uniti, ci ha insegnato che “la Costituzione di questo Paese non è altro che una creazione pensata per tenere il popolo al suo posto e per evitare che, anche solo per errore, abbia la cattiva idea di prendere in mano il proprio destino” (86). Allo stesso modo, Boron afferma che, contrariamente a quanto crede Negri, questo documento ci offre un chiaro esempio dell’alto grado di coscienza antipopolare e antidemocratica dei suoi creatori. Negri e Hardt vanno dunque considerati ingenui, opportunisti o esperti di marketing? E l’anarchico Chomsky non sta forse dando una lezione di marxismo al bolscevico Antonio Negri? Un’altra delle fantasie neoliberiste sostenute dagli autori di Empire è l’affermazione che lo Stato-nazione è in via di estinzione. Dobbiamo ammettere che è quantomeno divertente che Negri – un ammiratore di Lenin e, per di più, un vecchio stratega della presa del potere statale – tiri fuori dalla manica una simile assurdità oggi (87). Ciò è tanto più vero se si considera che tra le rare proposte pratiche dell’Impero ci sono quelle di un salario sociale (una rivisitazione del vecchio “salario garantito” di Potere Operaio) e di una cittadinanza globale. In altre parole, reddito e documenti garantiti per tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla classe o dalla condizione sociale. Senza voler entrare nel merito del significato politico e dell’opportunità di tali richieste, possiamo tuttavia sottolinearne l’aspetto paradossale: se lo Stato non esiste più, a chi si rivolgono Negri e Hardt?
Il processo di evoluzione dello Stato è, in realtà, terribilmente contraddittorio. Da un lato, l’ondata di privatizzazioni ha eroso le sue funzioni redistributive e la sua credibilità, distruggendo la sfera pubblica a favore del settore privato. Dall’altro, innalzando il livello di conflittualità, è stata costretta ad aumentare le sue funzioni repressive. Per questo oggi non abbiamo a che fare con il tipo di Stati degradati di cui parlano i neoliberisti sostenuti da Negri, ma piuttosto con una sorta di keynesianesimo di guerra che divora le risorse pubbliche, togliendo ai poveri per dare ai ricchi in proporzioni mai raggiunte prima (88), ed è a questo scopo che si alza eternamente lo spauracchio della guerra contro “Stati canaglia” (Iraq, Corea, Libia, Libano, ecc.) o contro nemici interni (89). Da tutto ciò si può concludere che, sia nella sfera economica che in quella politica, le funzioni svolte dallo Stato rimangono indispensabili per il capitalismo, poiché quest’ultimo non potrebbe sopravvivere una settimana se lo Stato cessasse di fornirgli non solo le garanzie politiche e militari di cui ha bisogno, ma anche enormi risorse economiche. Da questo punto di vista, il caso degli Stati Uniti è significativo: gli astronomici sussidi all’agricoltura o le misure di sostegno al settore del trasporto aereo dopo l’11 settembre dimostrano facilmente che l’appetito per questo tipo di sussidi non sembra diminuire.
Sulla questione dell’imperialismo, le riflessioni di Negri si basano, come sempre, su preoccupazioni legittime. Ovviamente, non possiamo che essere d’accordo con lui sulla necessità di rivedere le vecchie teorie, ma per farlo dovremmo innanzitutto riconoscere che – sebbene la dinamica delle loro relazioni sia in continuo mutamento (90) – tutti gli Stati sono potenzialmente imperialisti. In secondo luogo, bisognerebbe ammettere che nessuno Stato oggi è in grado di competere con gli Stati Uniti in campo militare, economico, politico o culturale, il che rende obsoleta una delle caratteristiche principali dell’imperialismo classico, come analizzato da Rosa Luxemburg, ossia l’esistenza di un certo livello di competizione tra Stati per la conquista di mercati, territori o materie prime (91). Dalla caduta del blocco sovietico, nessuno Stato o regione geopolitica è stato in grado di contrastare il potere degli Stati Uniti. Come chiamare questa nuova realtà? Impero? Imperialismo? Il nome, in realtà, ha poca importanza, non appena diventa chiaro che un solo Paese, gli Stati Uniti, sta imponendo un sistema planetario di Stati vassalli organizzati in sovranità limitate, un sistema che, ironia della sorte, assomiglia molto a quello che, per decenni, l’Unione Sovietica ha imposto ai suoi satelliti (92). Questo sistema richiede che gli Stati membri siano deboli all’esterno, cioè malleabili e sensibili alle esigenze americane, ma forti all’interno, cioè repressivi e capaci di imporre queste stesse esigenze ai loro subordinati.
Tuttavia, questo nuovo ordine mondiale continua a generare attriti e disagi, in particolare – ma non solo – tra le “classi pericolose” in un mondo sempre più afflitto da povertà, insicurezza e problemi ambientali. Gli zapatisti in Chiapas, i piqueteros in Argentina, i cocaleros in Bolivia, Lula in Brasile, Chavez in Venezuela e il nuovo corso in Ecuador sono tutti segnali di crisi nel cortile di casa dell’Impero. In Europa, i venti di Genova 2001 non hanno smesso di soffiare e le manifestazioni contro la guerra si sono moltiplicate. Quando ci sono rivolte, vengono dai movimenti sociali, come un “ya basta” generalizzato, e non attraverso i partiti politici che, salvo rare eccezioni, accettano l’ordine stabilito, anche quando sono di sinistra. Siamo quindi ben lontani dall’Impero deterritorializzante e decentralizzato teorizzato dai nostri autori. Gli eventi dell’11 settembre e la reazione che hanno provocato nell’amministrazione Bush dimostrano, ancora una volta, il fallimento del loro modello teorico: questa reazione è quella di uno Stato imperialista che pretende di adattare il pianeta ai propri interessi (93).
Oggi”, osserva Eric Hobsbawm, ”come per tutto il XX secolo, c’è una totale assenza di un’autorità globale efficace in grado di controllare o risolvere le dispute armate. La globalizzazione è avanzata in quasi tutti i campi – economico, tecnologico, culturale e persino linguistico – tranne che in uno, quello militare e politico. Gli Stati territoriali sono ancora le uniche autorità efficaci” (94). Proclamare la fine dello Stato non ci serve quindi a nulla. È addirittura un’idea dannosa, perché non contribuisce all’azione. E anche se questa affermazione può sembrare terribilmente banale, vale la pena ricordarla quando leggiamo sulla rivista Rebeldía che chi la fa si sente parte di “una sinistra che non è più disposta a continuare a perdere tempo a discutere di un potere nazionale che non esiste più” (95). Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Una cosa è dire, come ha fatto John Holloway – e prima di lui gli zapatisti, e prima ancora i libertari di ogni orientamento – che il mondo non può essere cambiato “prendendo” il potere dello Stato, e un’altra è dichiarare che il potere nazionale non esiste più (96). Chi sta mandando i carri armati in Chiapas? Chi sta armando i paramilitari? Chi c’è dietro il piano Puebla Panama? Il famoso apparato di de-centralizzazione e deterritorializzazione? Niente affatto! Si tratta di una potenza nazionale ben identificabile: lo Stato messicano. Gli Stati nazionali continuano a esistere e sono sia i nostri nemici che i nostri interlocutori. Di fronte a loro, non possiamo abbassare la guardia: dobbiamo fare pressione su di loro, lottare contro di loro, tormentarli. A volte dovremo negoziare con loro, ma lo faremo in modo autonomo. Gli zapatisti hanno dimostrato che questo è possibile, e se i risultati non sono stati all’altezza delle loro speranze, hanno almeno permesso loro, a differenza di altri, di mantenere la propria dignità. Il nostro cammino, quello dei movimenti per l’umanità e contro il neoliberismo, non è privo di ostacoli. Come suggerisce Michael Albert, direttore di Z Magazine (e del sito web Znet), oltre al radicalismo teorico e pratico, richiede duttilità, pazienza e una certa dose di pragmatismo (97). Perché è bene ripeterlo: il capitalismo e lo Stato-nazione, questi due mostri creati dall’Occidente, sono nati insieme e insieme scompariranno. E se non sapremo annegarli in un mare di risate, ci faranno compagnia ancora per un po’, come il dinosauro di Tito Monterroso (98).
Claudio Albertani Tepoztlán,
Morelos, Messico,
novembre 2002-gennaio 2003.
* Desidero ringraziare Gianni Armaroli, Gianni Carrozza, Clara Ferri, Malena Fierros, John Holloway, Furio Lippi, Raúl Ornelas e Tito Pulsinelli per i loro commenti e suggerimenti.
Note :
(1)
Michael Hardt e Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, 2000. [Qui seguiamo la versione francese (Exils Editeurs, 2000).
(2) Empire, “L’agonia della disciplina sovietica”, pp. 337-341.
(3) Impero, p. 19.
(4) M. Hardt, “Il tramonto del mondo contadino nell’Impero” in Posse. Política. Filosofia. Moltitudini, Edizioni Manifestolibri, maggio 2002.
(5) Atilio A. Boron, Imperio. Imperialismo. Una lettura critica di Michael Hardt e Antonio Negri, Buenos Aires, CLACSO, 2002.
(6) Michel Foucault, Microfísica del poder, Ediciones de la Piqueta, 1978, p. 7.
(7) Negri e Hardt avevano già preso le distanze dal postmodernismo nel loro libro Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Manifestolibri, 1995, pp. 25-28. In Empire si legge: “Le varie correnti di pensiero postmoderno [sono] sintomi di una rottura nella tradizione della sovranità moderna”, che “indicano il passaggio verso la costituzione dell’Impero” (p. 186).
(8) Qualche anno fa, Negri era l’autore di riferimento di alcuni marxisti americani. Uno di loro, Harry Cleaver, ha scritto che “se Marx non intendeva quello che dice Negri, beh, peggio per Marx” (sic). (Cfr. George Katsiafikas, La sovversione della politica. European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life, Humanities Press International, New Jersey, 1997, p. 226).
(9) Questa breve ricostruzione si basa sul libro di Nanni Balestrini e Primo Moroni, L’Orda d’Oro. 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Feltrinelli, Milano, 1997, e su quella di Oreste Scalzone e Paolo Persichetti, La Révolution et l’Etat. Insurrezioni e “contre-insurrezioni” nell’Italia dell’après-68, Dagorno, 2000. Si legga anche Futuro Anteriore. Dai Quaderni Rossi ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano, Derive/Approdi, Roma, 2002. Ho consultato anche il sito http://www.intermarx.com (in particolare gli ottimi scritti di Maria Turchetto e Damiano Palano), le riviste Vis-à-Vis e Primo Maggio, e un mio vecchio saggio pubblicato in forma anonima con il titolo “Proletari se voi sapete” in Al tramonto. Operaismo italiano e dintorni, supplemento alla rivista Insurrezione (Renato Varani editore, Milano, 1982).
(10) Franco Alasia, Danilo Montaldi, Milano, Corea, Feltrinelli, 1978, p. 184.
(11) R. Panzieri, La crisi del movimento operaio. Scritti, interventi, lettere, 1956-1960, Lampugnani, 1973. Panzieri è stato direttore della rivista teorica del PSI, Mondo Operaio.
(12) Cfr. R. Panzieri, Spontaneità e organizzazione. Gli anni dei Quaderni Rossi. Scritti Scelti, Biblioteca Franco Serantini, 1994.
(13) K. Marx, El Capital, Editorial Librerías Allende, 1977, pp. 328-330. [La stessa espressione “lavoratore collettivo” compare nella versione francese].
(14) Cfr. K. Marx, Il Capitale. Libro I, capitolo VI (inedito), Union générale d’éditions, 1971.
(15) R. Panzieri, “Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo” e “Plusvalore e pianificazione. Appunti di lettura del Capitale”, in Spontaneitá…
(16) Sergio Bologna, “Il rapporto fabbrica-società come categoria storica”, Primo Maggio, n. 2, Milano, 1974.
(17) Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino, 1977, sezione 22, “Americanismo e fordismo”, p. 2146.
(18) R. Alquati, Composizione organica del capitale e forza-lavoro alla Olivetti, Quaderni Rossi, n. 2, 1962, pp. 63-98. Nel 1975 questo autore ha raccolto i suoi scritti in Sulla Fiat e altri scritti, Milano, Feltrinelli.
(19) Danilo Montaldi, “Il significato dei fatti di luglio”, Quaderni di Unità Proletaria, n. 1, 1960. Montaldi era un intellettuale libertario vicino al gruppo Socialisme ou Barbarie. Pur non appartenendo alla rete, esercitò una forte influenza sui primi operisti.
(20) Oltre ai protagonisti già citati, facevano parte di Classe Operaia Giairo Daghini, Luciano Ferrari-Bravo, Guido Bianchini, Enzo Grillo (traduttore dei Grundrisse in italiano), Oreste Scalzone, Franco Piperno, Franco Berardi, Gianfranco Della Casa, Gaspare de Caro, Gianni Amaroli e Ricardo d’Este.
(21) Classe Operaia, n. 1, gennaio 1964. Ristampato in Mario Tronti, Operai e Capitale, Einaudi, Torino, 1966 (nuova edizione, 1971), pp. 89-95. (Una versione francese di questo testo è stata pubblicata da Christian Bourgois).
(22) Tronti, op. cit. pp. 298-299.
(23) Tronti, op. cit. pp. 81 e 84.
(24) Tronti, op. cit. p. 53.
(25) Tronti, intervista pubblicata su L’Unità, Roma, 8 dicembre 2001. In una precedente intervista, datata 8 agosto 2000, Tronti aveva detto: “Siamo stati vittime di un’illusione ottica”.
(26) Tronti, op. cit. p. 14.
(27) Nelle sue Considerazioni sul marxismo occidentale (New Left Book, Londra, 1976), Perry Anderson non dedica una sola riga all’operaismo italiano.
(28) Nella Dialettica negativa, Adorno afferma la supremazia dell’“oggetto” (traduzione italiana, Einaudi, 1975, pp. 156-157).
(29) Si veda, ad esempio, R. Panzieri, “Plusvalore e capitale”, op. cit. dove l’autore sottolinea l’unità del capitalismo come funzione sociale.
(30) Marx, Il Capitale, vol. I, p. 88.
(31) Pagine di Karl Marx. Selezionate, tradotte e presentate da Maximilien Rubel, 1 Sociologie critique, Payot, 1970, p. 103.
(32) Tronti, op. cit. p. 221.
(33) Impero, pp. 261 e 291.
(34) L’ultimo numero della rivista è apparso nel marzo 1967.
(35) Gianni Armaroli (collaboratore genovese di Classe Operaia), lettera all’autore, 30 dicembre 2002.
(36) I principali teorici dei consigli operai furono i tribunisti olandesi (così chiamati per il periodico da loro diretto, De Tribune) Anton Pannekoek e Herman Gorter; accanto ai tedeschi Karl Korsch, Otto Ruhle e Paul Mattick.
(37) Contrariamente a quanto spesso si dice (si veda, ad esempio, Octavio Rodríguez Araujo, Izquierdas e izquierdismos. De la Primera Internacional a Porto Alegre, Siglo XXI editores, 2002, p. 115), Bordiga non era un consigliere, ma un convinto sostenitore dell’idea bolscevica di partito. A questo proposito, si veda la polemica che intrattenne con Gramsci in Antonio Gramsci-Amadeo Bordiga. Debate sobre los consejos de fábrica, Editorial Anagrama, 1973. Tuttavia, fu Bordiga – fondatore e primo segretario del PCI – e non Gramsci, ad opporsi alla bolscevizzazione dei partiti occidentali, imposta dall’Internazionale Comunista a partire dal 1923.
(38) Intorno al 1967, a Genova nascono il Circolo Rosa Luxemburg, la Lega Operai-Studenti e la Ludd-Consigli Proletari (presenti anche a Roma e Milano). A Torino, l’Organizzazione Consiliare fu fondata nel 1970 e il Comontismo nel 1971. Pur essendo una minoranza, questi gruppi furono significativi e furono praticamente cancellati dalla storia del movimento sessantottino.
(39) Nel 1969, Sergio Bologna e altri fondarono La Classe, una rivista che fungeva da portavoce delle lotte operaie alla Fiat. Bologna partecipò alla fondazione di Potere Operaio e negli anni Settanta e Ottanta diresse la rivista Primo Maggio, un baluardo dell’operaismo originale.
(40) Tronti, intervista citata, 8 agosto 2000.
(41) Tra il 1968 e il 1971, il tentativo portò alla creazione della rivista Contropiano, diretta da Asor Rosa e Cacciari, alla quale contribuirono sia Tronti che Negri.
(42) M. Tronti, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, 1977, pp. 7, 19 e 20.
(43) Eduardo di Giovanni, Marco Ligini, La strage di Stato, Samonà e Savelli, 1970 (nuova edizione Avvenimenti, 1993).
(44) Tra le idee più curiose di Negri c’è il suo elogio dell’“assenza di memoria”. Si veda Antonio Negri, Du Retour. Abécédaire biopolitique, Calmann-Lévy, 2002, p. 111.
(45) Cfr. A. Negri, Du retour.
(46) Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano, comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Feltrinelli, 1972, p. 181. Questo “neoleninismo insurrezionale” sarà sistematizzato in A. Negri, La fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin, Libri Rossi, 1977.
(47) Uno dei gruppi più noti di questa tendenza fu il Collettivo di via dei Volsci, di Roma, che avrebbe presto fondato Radio Onda Rossa, una stazione del movimento tuttora esistente.
(48) Negri sviluppò il tema dell’autovalorizzazione in Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale. Feltrinelli, 1978. Si veda anche Impero, pp. 491 e 493.
(46) Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano, comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Feltrinelli, 1972, p. 181. Questo “neoleninismo insurrezionale” sarà sistematizzato in A. Negri, La fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin, Libri Rossi, 1977.
(47) Uno dei gruppi più noti di questa tendenza fu il Collettivo di via dei Volsci, di Roma, che avrebbe presto fondato Radio Onda Rossa, una stazione del movimento tuttora esistente.
(48) Negri sviluppò il tema dell’autovalorizzazione in Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale. Feltrinelli, 1978. Cfr. anche Impero, pp. 491 e 493.
(49) A. Negri, Proletari e Stato. Per una discussione su autonomia operaia e compromesso storico, Feltrinelli, 1976, p. 30. La questione della dissoluzione della società civile nello Stato è ripresa in Impero, pp. 51, 398-399.
(50) Agnès Heller, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, 1977, p. 26.
(51) A. Negri, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, 1979, p. 194.
(52) A. Negri, Il dominio…, pp. 61 e 70.
(53) Negli anni Settanta, in Italia, decine e probabilmente centinaia di gruppi praticarono la lotta armata. Oltre alle Brigate Rosse, questi includevano, tra i tanti, i Nuclei Armati Proletari (NAP), Prima Linea, Mai più senza fucile, Azione Rivoluzionaria e Proletari Armati per il Comunismo.
(54) Contrariamente a quanto ho letto su Memoria, n. 167 (gennaio 2003, p. 5), non è mai esistito in Italia un gruppo chiamato “Autonomia operaia”. Negri era a capo di una delle tante organizzazioni che formavano il campo dell’Autonomia Operaia.
(55) Sul tragico esito della lotta armata, si veda Cesare Bermani, Il nemico interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), Odradek, 1997.
(56) Rosso, maggio 1978. La rivista, pubblicata a Milano, era l’organo del Gruppo Gramsci, un’organizzazione guidata da Negri.
(57) Dopo due anni di carcere, Negri viene rilasciato quando viene eletto deputato nella lista del Partito Radicale. Nel 1983 andò in esilio in Francia.
(58) Negli anni Ottanta e Novanta, il progetto di un operaismo libertario rimase vivo nel pensiero di alcuni collettivi come Primo Maggio, Collegamenti-Wobbly e Vis-à-Vis.
(59) Impero, pp. 183 e 187.
(60) A. Negri, Marx oltre Marx, p. 55.
(61) A. Negri, Marx oltre Marx, pp. 24-25.
(62) A. Negri, Spinoza, p. 394. Questa edizione comprende: L’anomalia selvaggia (1980), Spinoza sovversivo (1985) e Democracia e eternità in Spinoza (1994), i principali testi spinoziani di Negri.
(63) Si veda ad esempio Karl Korsch, Karl Marx, Laterza, 1970, p. 101.
(64) A. Negri, Spinoza, p. 35.
(65) Ho cercato, senza successo, una spiegazione soddisfacente del concetto di “moltitudine” nell’opera di Negri. Uno dei suoi discepoli, Paolo Virno, si è apparentemente assunto il compito in Grammatica della moltitudine. Per un’analisi delle forme di vita contemporanee, Derive/Approdi, 2002.
(66) Norberto Bobbio-Michelangelo Bovero. Sociedad y Estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, FCE, México, 1994, p. 94.
(67) A. Negri-M. Hardt, Il lavoro di Dioniso, p. 27.
(68) Impero, p. 140.
(69) Impero, pp. 354-359.
(70) K. Marx, Grundrisse, vol. II, p. 228.
(71) Grundrisse, pp. 228-229.
(72) Grundrisse, p. 230.
(73) Disponibile su www.intermarx.com: Maria Turchetto, “Dall’operaio massa all’imprenditorialità comune. La sconcertante parabola dell’operaismo italiano”.
(74) Impero, p. 359.
(75) Lettera di Negri scritta dal carcere di Rebibbia (Roma), datata 10 settembre 1997, secondo la versione diffusa su Internet.
(76) Dans Il lavoro di Dioniso, pp. 29-30, Negri avoue accepter les théories de Mario Tronti sur l’autonomie du politique. Dans Empire, en revanche, il nous informe de la disparition de « la notion de l’autonomie du politique » (p. 375).
(77) Empire, p. 496.
(78) D’après le dictionnaire de la Real Academia, un « militant » est quelqu’un qui se voue à la milice… Les premières critiques de la figure du militant remontent à 1966 et sont dues à l’Internationale situationniste. Voir De la misère en milieu étudiant, traduit dans une vingtaine de langues.
(79)Non è un caso che i principali discepoli di Negri, i Disobbedienti (precedentemente noti come Tute bianche o Associazione Ya Basta), siano una fonte di grande confusione nel cosiddetto movimento di alter-globalizzazione. Combinano il peggio della politica della vecchia sinistra con il peggio dell’attivismo mediatico. Radicali all’estero (sono stati espulsi con grande clamore dal Messico nel 1998), sono disposti a scendere a compromessi in Italia; pacifisti convinti, rilasciano deliranti dichiarazioni di guerra al governo italiano (ma non sanno essere coerenti); zapatisti dichiarati, aspirano a cariche elettive… Sulle incongruenze delle Tute bianche (ora Disubbidienti), si veda “Paint it Black. Blocchi neri, tute bianche e zapatisti nel movimento contro la globalizzazione”, di Claudio Albertani, pubblicato contemporaneamente su Collegamenti-Wobbly, n. 1, gennaio 2002 e, in francese, su Les Temps maudits, n. 12 (gennaio-aprile 2002). Una versione inglese è apparsa su New Political Science, Londra, dicembre 2002). Per ulteriori informazioni sulle attività dei Disubbidienti, vederewww.ecn.org/movimento.
(80) “Discorsi zapatisti, manifestazione a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 1 gennaio 2003”, disponibile su http://chiapas.indymedia.org.
(81) Sul feticismo del lavoro di Negri, si veda G. Katsiafikas, op. cit. pp. 225-232.
(82) Riprendo questo argomento dal saggio di Maria Turchetto “L’impero colpisce ancora” (http://www.intermarx.com).
(83) Impero, p. 474.
(84) Impero, p. 459.
(85) Hannah Arendt, On Revolution, (ristampato da Vicking Press, 1996), in particolare il capitolo III. Negri aveva già lodato la Costituzione americana in Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, SugarCo, 1992.
(86) Citato in Boron, op. cit. p. 110.
(87) Nel tentativo di risparmiare Dio e il diavolo, Negri formula la seguente domanda: “Cosa fare del leninismo nelle nuove condizioni del potere del lavoro? [Quale soggettività dovrà essere prodotta perché il proletariato immateriale prenda oggi il potere? E risponde: “Dobbiamo portare Lenin oltre Lenin, […] verso la democrazia assoluta della moltitudine” (!) Cfr. Toni Negri, “Che farne del Che fare? Ovvero il corpo del General Intellect”, Posse, maggio 2002, pp. 123-133.
(88) Si vedano le recenti misure di Bush a favore degli speculatori finanziari, che includono un taglio fiscale di 300 miliardi di dollari sui dividendi degli azionisti.
(89) La guerra contro un singolo individuo, a volte, come abbiamo visto con Bin Laden. Se si crede alle recenti dichiarazioni della Casa Bianca, è probabile che questo ciclo duri almeno trent’anni.
(90) Uno degli errori di Lenin è stato quello di credere che l’imperialismo fosse semplicemente una “fase” del capitalismo quando, in realtà, faceva parte della sua logica fin dall’inizio.
(91) Stefano Capello, “L’imperialismo da Disraeli a Bush”, Collegamenti n. 2, 2002.
(92) Tito Pulsinelli, “Sobre el señor y los vasallos. Estados Unidos en el atardecer del neoliberalismo”. Disponibile su www.lafogata.org/02inter/8internacional/sobre.htm
(93) Negri si sentiva molto a disagio per questi eventi. Inizialmente ha interpretato la caduta delle Torri Gemelle come un affare interno all’Impero, qualcosa che “appartiene” solo ad esso, prima di correggersi, sostenendo che si tratta di una reazione imperialista contro l’Impero. Hardt, da parte sua, ha sostenuto questa seconda versione in un recente articolo in cui esortava “le élite ad agire nel proprio interesse come rete imperiale decentrata, interrompendo così il processo di conversione degli Stati Uniti in una ‘potenza imperialista secondo il vecchio modello europeo’”. Un appello curioso, in effetti, proveniente da un profeta della “moltitudine”! Du retour, p. 185 e p. 209. Intervista pubblicata su Il Manifesto, 14 settembre 2002.
(94) Eric Hobsbawm, “La guerra y la paz en el siglo XX”, La Jornada, Messico, 24 marzo 2002.
(95) Rebeldía, editoriale del numero 1, Città del Messico, novembre 2002.
(96) John Holloway, Cambiare il mondo senza prendere il potere, Pluto Press, 2002. Molti commentatori hanno erroneamente accomunato Holloway e Negri.
(97) Benedetto Vecchi, “Democrazia in Movimento”, Il Manifesto, 18 gennaio 2003.
(98) Claudio Albertani si riferisce qui a un famoso racconto del romanziere Tito Monterroso, che ha la particolarità di contenere un’unica frase: “Al día siguiente, cuando despertó, el dinosaurio seguía todavía ahí”, che è di fatto intraducibile, poiché il soggetto della subordinata non è spiegato e non si sa se si riferisca a “él”, “ella” o addirittura “Usted”: “Il giorno dopo, quando si svegliò [oppure: “quando si svegliò” o: “quando ti svegliasti” o “ti svegliasti”], il dinosauro era ancora lì”. ” (NdT).